Non lasciatevi ingannare dal titolo. Elogio dell’ignoranza e dell’errore, l’ultima fatica di Gianrico Carofiglio, non è un’esaltazione dell’assai diffusa tendenza all’insipienza. Lo scrittore barese, al contrario, ha voluto instillare il dubbio in chi dubbi non ne ha mai. «A primavera scorsa parlando con il mio editore è venuta fuori l’idea di scrivere una specie di quadernetto su una riflessione che stavo portando avanti da diversi anni.
In particolare il tema dell’errore è il frutto di una presa di coscienza personale legata alla mia difficoltà di riconoscere gli sbagli che commettevo e alla tendenza a rielaborare con argomenti apparentemente impeccabili scelte, decisioni e intuizioni sbagliate. Quando me ne sono reso conto, è stato scioccante».
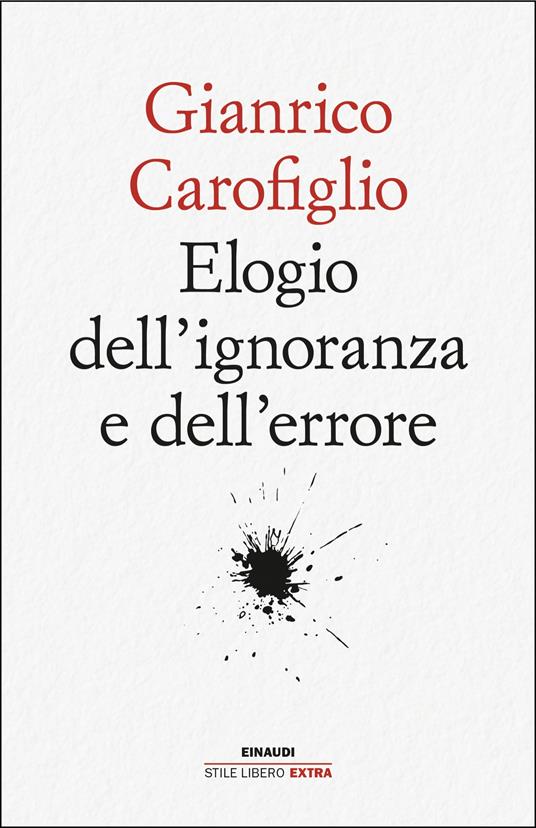
Quando parla di elogio dell’ignoranza, si riferisce a un’accezione particolare di questo termine?
Non è certamente un elogio dell’ignoranza arrogante, stupida e tanto diffusa nella nostra vita individuale e collettiva, ma dell’ignoranza consapevole che è la premessa della conoscenza, dello stupore, dell’ammirazione legata alla bellezza, è l’ignoranza di chi conosce alcune cose, ma sa che ce ne sono tante altre che non conosce e considera questa un’opportunità.
Perché è importante sbagliare, ma soprattutto riconoscere e ammettere i propri sbagli?
Sbagliare non è importante, è inevitabile. Quindi il primo passo da fare è riconoscere la verità e i propri errori con se stessi e con gli altri. Perché dall’errore e dal fallimento scaturiscono possibilità che non vediamo, se non ammettiamo lo sbaglio. Se invece lo riconosciamo, si aprono opportunità che possono cambiare positivamente la nostra vita.
Il secondo passo qual è?
Imparare a sbagliare in maniera il più possibile sicura e non dannosa, diciamo imparare a cadere con eleganza. E a rialzarsi.
Nel libro cita l’esempio delle arti marziali, sport a lei caro: infatti è cintura nera di karate.
È la miglior metafora disponibile perché la prima cosa che si impara nel karate è cadere senza farsi male e rialzarsi velocemente. È una disciplina che conosco bene.
Nel libro ricorda che tante scoperte scientifiche sono nate da errori…
La più famosa è quella della penicillina: Alexander Fleming lasciò delle piastre con delle colture batteriche non adeguatamente protette e si sviluppò una muffa che uccise molti batteri. Fu così che si scoprì il primo antibiotico: a partire da una disattenzione.
C’è una categoria, quella degli esperti anche televisivi, che raramente riconosce i propri errori…
Ci sono numerosi studi scientifici su migliaia e migliaia di previsioni da cui emerge che l’attendibilità degli esperti è al limite della casualità. Se approfondiamo il dato, vediamo che a fronte di tanti che sbagliano, perché troppo intrappolati nella loro conoscenza, ce ne sono alcuni con un più alto grado di attendibilità e sono quelli che incorporano l’errore, accettano e sollecitano le critiche, sono capaci di vedere un problema da più punti di vista. Quando siamo molto competenti, pensiamo che la nostra conoscenza esaurisca tutto, se invece usiamo la competenza come un punto di partenza, allora si arriva a risultati inaspettati.
Lei loda anche la capacità di improvvisare; in che senso?
È una parola che può avere anche un’accezione negativa, se dietro all’improvvisazione non c’è una solida preparazione; invece nella musica così come in altre arti la capacità di improvvisare ha un grande valore e coincide con l’apertura mentale e con la capacità di far saltare gli schemi se necessario. Coincide con la flessibilità di fronte alla complessità imprevedibile del mondo.
Nel libro ci sono tante citazioni, si va dal filosofo Platone al giocatore di basket Michael Jordan; ce n’è una che preferisce?
Per ridere, dico quella del pugile Mike Tyson: «Tutti hanno un piano, finché non prendono un pugno in bocca». Questa è un’ottima sintesi di cosa succede se si hanno piani troppo circostanziati.

